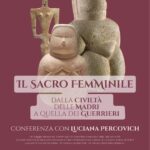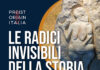Chi è la Margherita, e chi sono i ribelli, del titolo? Le risposte sono: la compagna di fra’ Dolcino e il gruppo di eretici, o meglio di rivoluzionari, a cui il carismatico predicatore aveva dato vita. Fino ad ora avevo trovato, come tanti, questi nomi e tracce di questa storia solo ne Il nome della rosa e in Mistero buffo. La cancellazione, o la deformazione, già spietate, di questa vicenda si sono accanite ancora di più su Margherita, di cui ora si sa solo che era la compagna (o “l’amica”, come si diceva ancora in tempi non lontani) di Dolcino. Il romanzo di Fabrizio Bozzetti cerca di restituirle un ruolo proprio, una personalità e un’evoluzione, senza lasciarsi scoraggiare dalla mancanza di dati sulla sua vita e riuscendoci, secondo me, molto bene.
La storia inizia nel 1303, quando Margherita Boninsegna, adolescente diciassettenne appartenente all’ aristocrazia di Arco, in provincia di Trento, viene rinchiusa in monastero dal fratello minore perché rifiuta il pretendente che le ha scelto. In lei c’è qualcosa che la rende “unica”: “la schiettezza quasi sfrontata con cui guardava il mondo, la scintilla che s’intuiva in fondo a quegli occhi azzurri sempre vivaci”. Ama la lettura e lo studio e il fratello, per mortificarla e piegarla ulteriormente, chiede alla badessa di impedirglieli. La badessa la mette a lavorare nell’orto, dove si coltivano anche erbe medicinali, ma in questo modo non solo le dà qualcosa di nuovo a cui interessarsi, ma la mette sulla strada che le riserva il destino: un giorno arriva in convento, in cerca di un riparo temporaneo, Francesca, una viandante che conosce le erbe medicinali molto meglio della suora erborista, una donna diversa da tutte quelle che Margherita ha conosciuto fino a quel momento. Pensando di poter ottenere il suo aiuto per viaggiare fino alla frontiera con la Francia, dove ha una zia che potrebbe darle rifugio, Margherita la segue scappando dal convento. Da lei imparerà non solo molti segreti delle erbe, ma anche che una donna può vivere come vuole senza chiedere il permesso a nessuno. Ma Francesca è un’eretica, una seguace di Dolcino, e un giorno viene arrestata. Finirà sul rogo. Margherita, che assiste disperata alla sua morte, incontra Dolcino e i suoi seguaci, sparsi tra la folla, e chiede al predicatore di poter proseguire con loro il suo viaggio. Inizia così il suo percorso, tra curiosità, scetticismo e inevitabili pregiudizi, che danno vita a diversi duelli verbali con Dolcino, capace di prenderla sul serio e dominare il fastidio di essere contraddetto “specie da una donna, per giunta giovane”. Gli altri membri del gruppo diffidano di lei in quanto aristocratica, ma la sua partecipazione alle attività comincia a produrre qualcosa di nuovo: è lei a ottenere protezione per le donne dalle violenze che anche alcuni nuovi arrivati maschi si sentono autorizzati ad esercitare, a proporre che anche le donne votino nelle assemblee, a convincere le madri a lasciarla insegnare a leggere e a scrivere alle figlie. Insomma, mette in moto una rivoluzione femminista all’interno del gruppo, anche se forse l’autore esagera l’insicurezza delle altre donne, considerando sia il personaggio di Francesca, che non si vede perché dovesse essere eccezionale nel gruppo, che il gran numero di donne, e il rispetto di cui godevano, nei movimenti “ereticali”.
Il movimento di Dolcino non suscita soltanto ostilità tra i potenti: ce ne sono anche alcuni che lo appoggiano. In occasione dell’incontro con uno di loro, Lodrisio Crivelli, signore di Trezzo, Dolcino chiede a Margherita di accompagnarlo perché, come aristocratica, “sa come comportarsi”. E’ l’occasione per l’incontro con “un guelfo bianco, ambasciatore fiorentino, a nome Dante”, allora già in esilio, unito a Dolcino dal comune odio per Bonifacio VIII, che lo fa apparire a Margherita come un uomo “roso dall’ossessione”. L’apparizione di Dante non è casuale, dato che ricorda Dolcino nella Divina Commedia, come l’autore riporta nell’appendice bibliografica che chiude il libro. Un altro sostenitore di Dolcino (che, opportunista come tutti i potenti, lo abbandonerà quando la situazione diventerà davvero pericolosa) è Matteo Magno Visconti, da cui Margherita ottiene una scorta di uomini d’arme per il gruppo. Visconti lascia la scelta degli uomini a lei, che si rivela capace di scegliere i migliori. A differenza del loro signore, non tradiranno la loro missione, restando al fianco del gruppo fino alla fine. Così farà Margherita, anche se deciderà solo all’ultimo, quando la sua strada dovrebbe dividersi da quella dei suoi compagni per proseguire verso la Francia. Anche accettare l’amore di Dolcino le richiederà tempo, perché tutto quello che ha visto nella vita le ha insegnato a temere l’amore, che per una donna può significare perdersi.
La storia di Margherita diventa così inscindibile da quella del movimento, con la nascita di una comunità stanziale, il suo iniziale successo, l’assedio, prima condotto a forza di propaganda e poi con le armi, la lotta, la fine tragica. Nell’ultimo capitolo, narrato in prima persona, l’autore immagina che a Margherita venga offerta la possibilità di salvarsi se accetta di rientrare nei ranghi del destino che la sua nascita le ha riservato, e che la rifiuti.
Margherita dei ribelli è un romanzo appassionato e appassionante, capace di restituire in maniera convincente non solo l’evoluzione di una giovane donna, ma l’atmosfera di un’epoca, con la violenza e l’ ingiustizia continuamente incombenti, e doppiamente sulle donne, la “fame e sete di giustizia” dei poveri, l’opposizione tra l’ipocrisia della chiesa ufficiale e la fede profonda che contribuisce ad alimentare il coraggio degli oppressi. E’ un altro tassello nella ricostruzione della storia e della memoria delle lotte di liberazione, delle donne e non solo, con l’auspicio che illuminino il presente, perché come ricordava Gustav Mahler, citato in una delle epigrafi di apertura, “la tradizione non è adorare le ceneri, ma custodire il fuoco”
Irene Starace